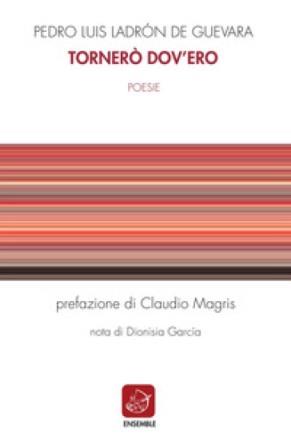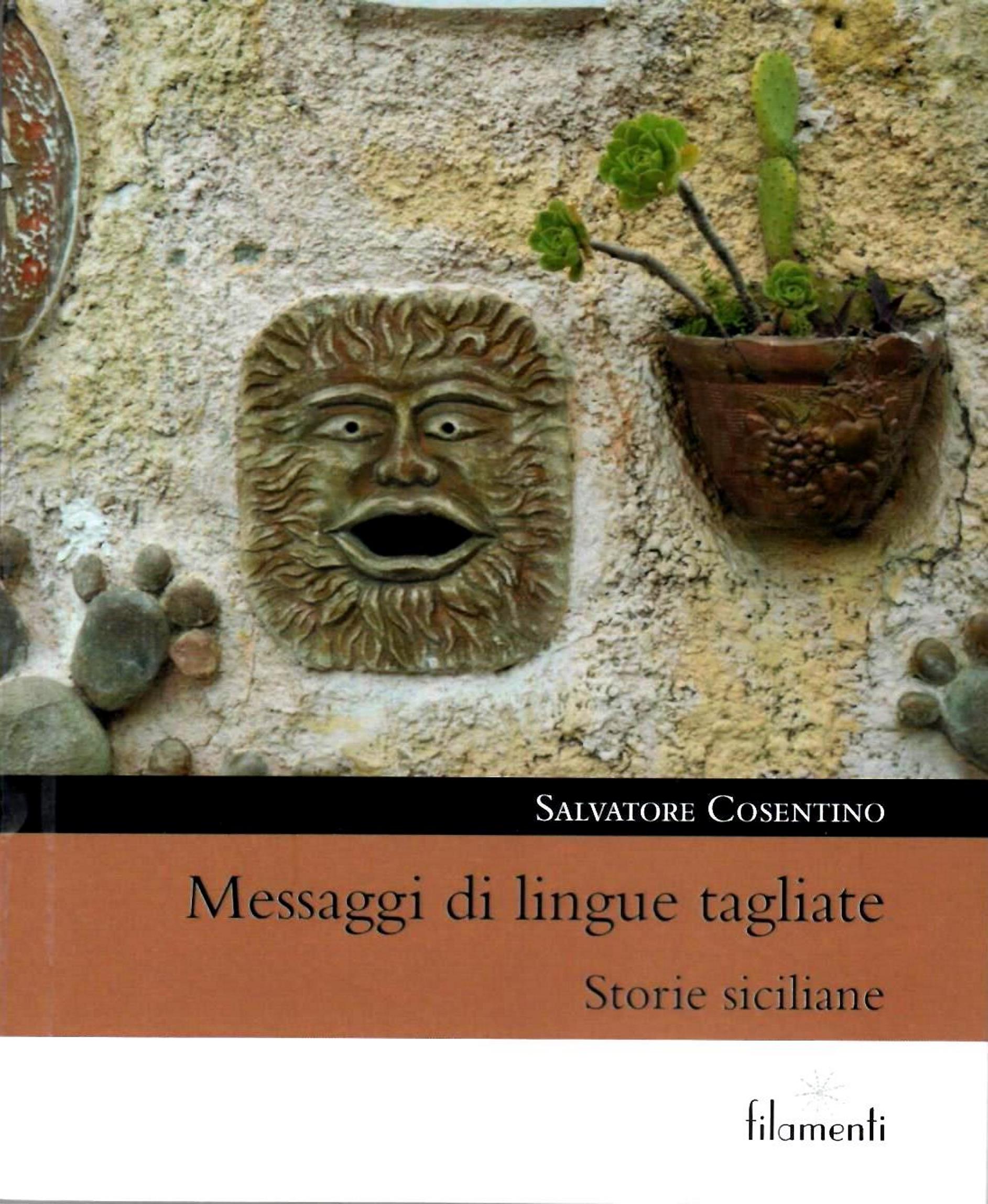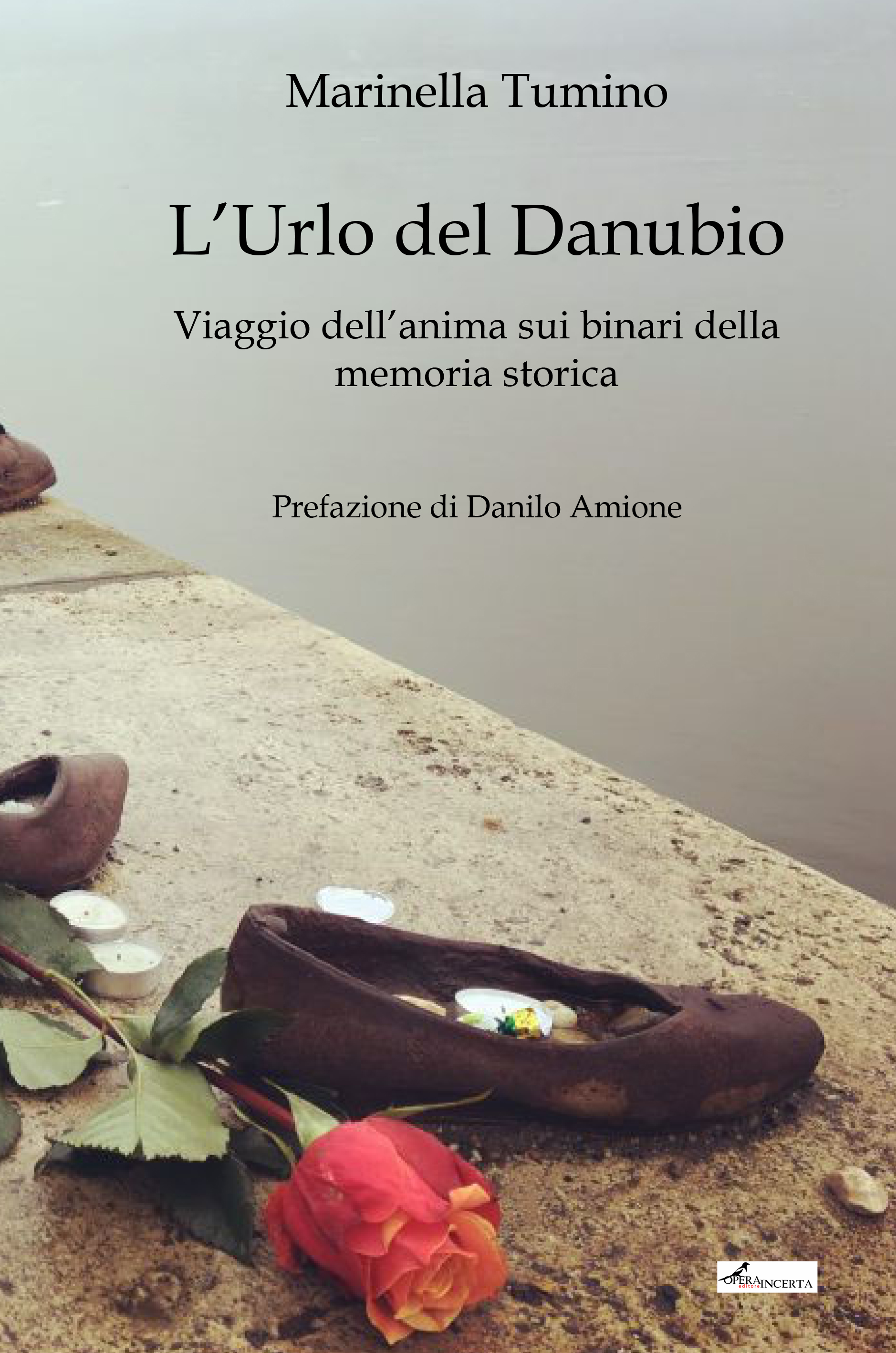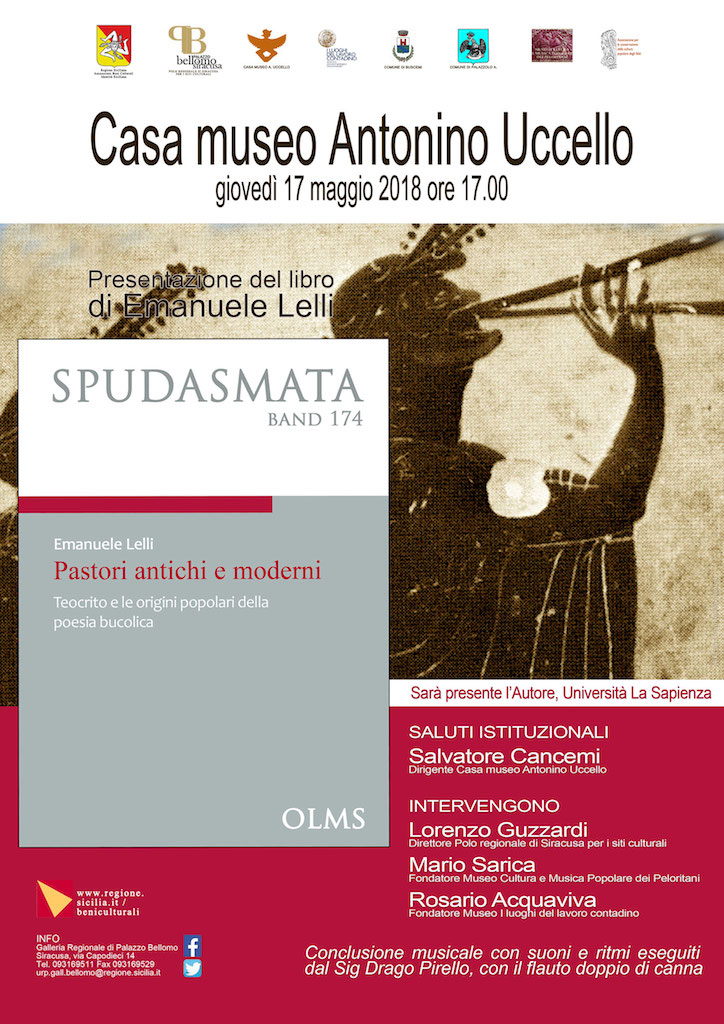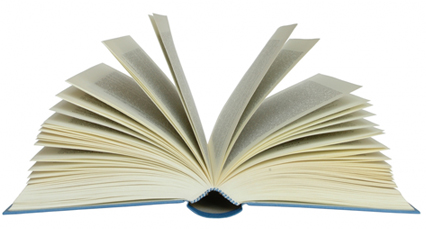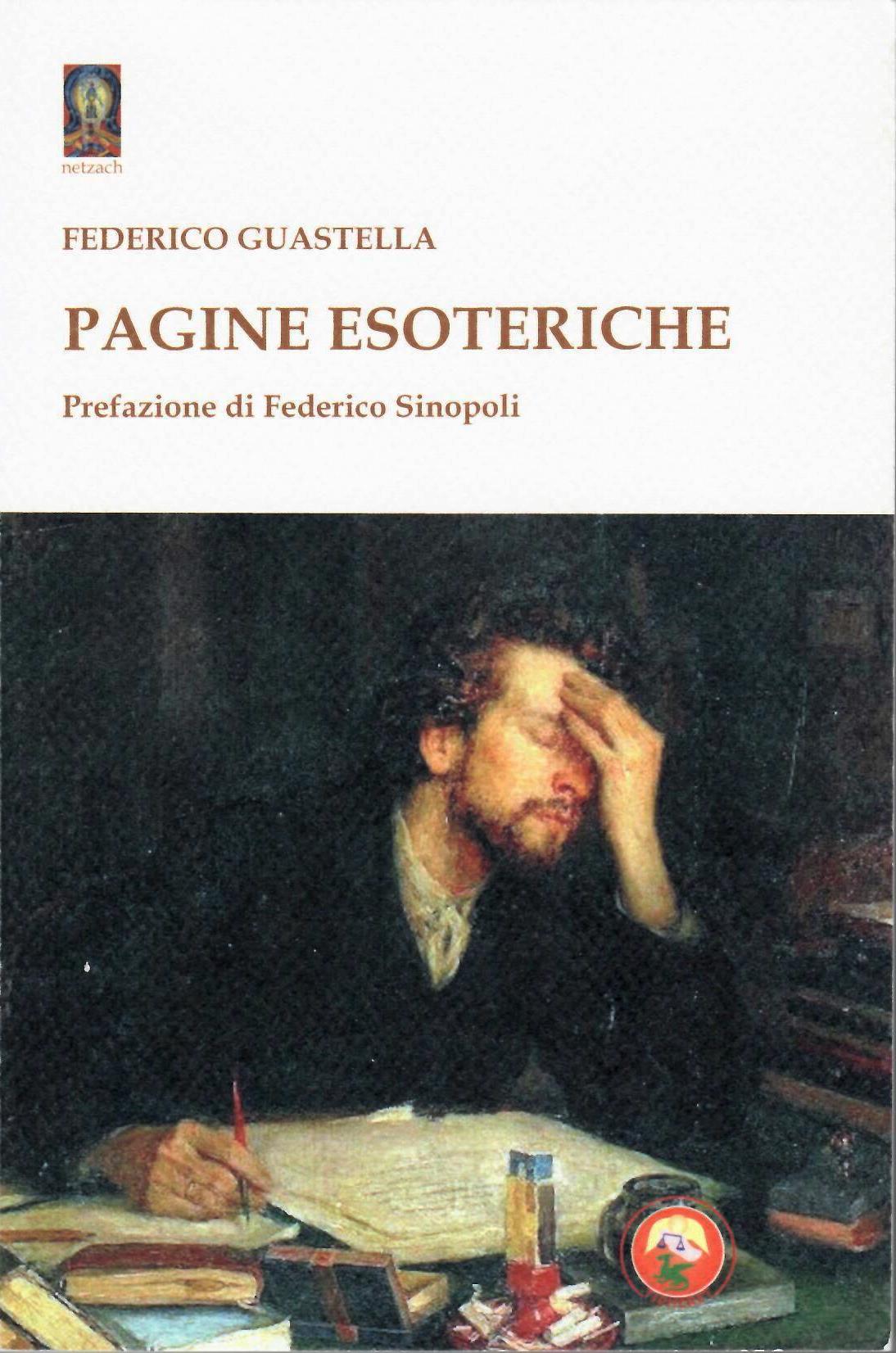L’ardente opera poetica di Pedro Luis Ladrón de Guevara
Il titolo, Tornerò dov'ero, un'allusione al primitivismo delle origini contro la disumanizzazione dell'era contemporanea? Un rifugio di salvezza per una civiltà nuova e nobilitante, non gravata e degradata dal peso assurdo della violenza e della sopraffazione, hobbesianamente lupesca? Certamente, questo e altro ancora. Parliamone, parliamo dell'accoramento di questo poeta spagnolo, di Murcia, Pedro Luis Ladrón de Guevara, italianista e autore di opere di poesia, di narrativa e di saggistica letteraria: un poligrafo, insomma, immerso nei ricordi ovvero i sogni di un passato che si fa desiderio e fuga dal presente, cioè dalla realtà degli affanni di una Storia ripudiata, da vilipendere, dimenticare: quella delle ingiustizie, delle sopraffazioni, delle persecuzioni, dei soprusi, delle barriere dove “L'umanità svanisce, si spegne/ [...]”. E in tutto questo assistiamo alla celebrazione di un'elegia che diviene religio della vita. C'è uno strazio nel cuore di questo poeta: la sorte dei migranti ovvero degli “ultimi”, che già ai primi del '900 scossero la sensibilità di uomini e grandi intellettuali come Benedetto Croce, Edmondo De Amicis, Mario Rapisardi, per non dire della filantropa - cent'anni fa - Francesca Cabrini, che costruì a Chicago un ospedale per loro. Ebbene, Pedro Luis è di quelli che vanno verso una coscienza universale e una civiltà cosmopolita; e sa bene che è in atto una trasformazione geopolitica epocale a causa del flusso migratorio.
È come se condividesse (e certamente è così) le istanze di quel Breviario Mediterraneo di Predag Matvejevic che già nel 1987 aprì la mente di tanti alle grandi riflessioni sull'uomo e sulla Storia. Oggi, l'emigrazione e i migranti sono al centro dell'attenzione della “Biennale Internazionale di Fotografia” dedicata al tema: “Mediterraneo, immenso archivio e profondo sepolcro”; e credo di non sbagliarmi, affermando che il nostro Poeta abbia tenuto in considerazione tutto questo, concependo i suoi versi, insieme ai grandi problemi di un Medio Oriente in pericolosa ebollizione. Penso, tra gli altri Stati, alla Siria, a Israele, alla Palestina. Ma l'arte, si sa, nasce anche dal sangue del mondo, ahimè! Ce ne dà ragione il componimento L'umanità svanisce, i cui versi mi ricordano quelli di Justo Jorge Padrón laddove, in E se Dio si stancasse di noi, dice: “Per non farci più amare/ verserebbero su di noi l'ambizione, / l'invidia, la violenza, la lussuria, l'odio...”; ma mi ricordano anche l'altro grande poeta spagnolo Manuel Vásquez Montalbán, in Morirà questa storia nella Storia (cfr: Il desiderio e la rosa): “di esplosione negli occhi/ frantumeranno le schegge/ della città vinta/ i corpi sono il mio corpo/ vita storia rosa carrarmato ferita”. Nell'uno e nell'altro vi ritrovo il pensiero critico del trappista Thomas Merton, soprattutto là dove affiora il rifiuto del materialismo consumista e l'anelito alla pace costruttiva tra i popoli della terra. Mi pare di cogliere il sospiro affranto del poeta nell'ossessiva auscultazione della natura che si ribella alle ingiustizie e ai soprusi dell'uomo sui propri simili: una storia che indispettisce il mondo e offende Dio. Ecco, questo di Pedro Luis è un teatro dello smarrimento e del dolore: qui, è l'elegia della Storia che nel dolore esistenziale rasenta la preghiera e diviene misura dell'ingiustizia dei confini e delle civiltà che si guardano in cagnesco.
Il lettore attento non può non notare che questa poesia, assai problematica, è costruita su segni di mutazioni epocali e che il cruccio e l'ansito civile contenuti nell'ansia delle parole ferite dalla rivolta o dall'indignatio del pensiero si fa condanna della Storia e, per contrasto, larvata speranza dell'uomo che vuole rinascere, come qui in Primato: “Rinascerà il pianeta:/ cancellerà Natura/ l'impronta prepotente/ distesa nella Storia/ da questo essere ingrato. / Umano poco umano”. Più di una tensione civile! E' tensione evangelica, ma anche condanna insistita contro il negativo e il destruens del mondo. Come un anatema che nega, nel grido, “il futuro del mondo”, prospettando la minaccia della fine. E se vogliamo dire di più: tutto il discorso poetico di Pedro Luis è riassumibile nelle parole toccanti di Esodo: “Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri nel paese d'Egitto”.
Come si vede, l'attenzione all' “Altro” qui è espressa attraverso la poetica dell'umanitarismo civile e biblico, come per esempio nelle allusioni in Non sarai corpo: “che hai fatto per quei popoli/ assediati dalla fame/ per quei figli dagli occhi grandi/ e dagli ancor più gonfi stomaci”. Siamo al momento cruciale dell'êthos biblico del “dopo” o dell'éschata, le cose ultime, ovvero la resa dei conti a Dio: “[...]/ guarderai il Suo volto senza confini/ e vedrai in un istante la tua apatia/ intinta nello sconforto/ dei popoli innocenti”.
Il solco di Romolo e il fratricidio: la morte di Remo per mano del fondatore di Roma, secondo la leggenda; il confine, nel concetto rousseauiano secondo il Contratto sociale: delimitare una proprietà è già un segno di inimicizia verso l' “Altro”, il vicino, il confinante che si deve attenere a regole precise, pena la guerra e la morte. Questo motivo ritorna nel testo Rompendo le frontiere: “Non tracciare, figlio mio, / sulla mappa le frontiere. / Non solcare il planisfero/ con dei tratti in carboncino”.
Ebbene, questo motivo ritorna, più drammatico, in Lacrime sul mare: “Il figlio perso nella notte/ solcata da fragile zattera/ da un vecchio Continente a un altro, / dalla guerra crudele alla pace,/ da quasi assoluta miseria/ alla speranza in un domani”.
Che dire?, in questo libro c'è tutta la cronaca cruenta, drammatica della Storia contemporanea mondiale, dove la morte regna sovrana e sovrano è il simbolo del disprezzo della vita. Si leggano in questo senso i versi di Morire per te, che suonano come un avvertimento Ai membri di alcune ONG, a cui il testo poetico è dedicato. Soprattutto come disprezzo anatema condanna: “Sopravvivere a tante armi vendute/ da padroni con i diamanti al collo. / Campo di rifugiati, di massacrati/ bambini. I missili pagano il caviale”.
E’ il canto del tragico intonato sulla nota alta e toccante della Babele del mondo sempre più posseduto dai disvalori del crimine per i vecchi trenta denari!
Giovanni Occhipinti
***
Pedro Luis Ladrón de Guevara
(Cieza, 1959) Insegna Lingua e Letteratura italiana all'Università di Murcia. Si è occupato, con studi e traduzioni, di numerosi scrittori italiani classici e contemporanei, tra i quali Leopardi, Campana, Ungaretti, Luzi, Caproni, Magris, Tabucchi. Come poeta ha pubblicato Itinerarios en la penumbra (2003), la raccolta bilingue ispirata all’Italia Cuando la piedra habla/Quando la pietra parla (2004), Escarcha sobre la lápida (2007), Del sudor de las sirenas (2015). Tra le sue opere narrative si segnalano i racconti di Los mundos de mi mundo (2005) e El donante y otras historias (2015) nonché il romanzo La campana rasgada (2013).
Coltiva anche l’arte della fotografia, come testimonia il volume Viaggio in un’Italia senza tempo (2015) che riunisce insieme versi e immagini dedicati al nostro paese.
Ultima fatica letteraria Tornerò dov’ero (2018, pp. 82)